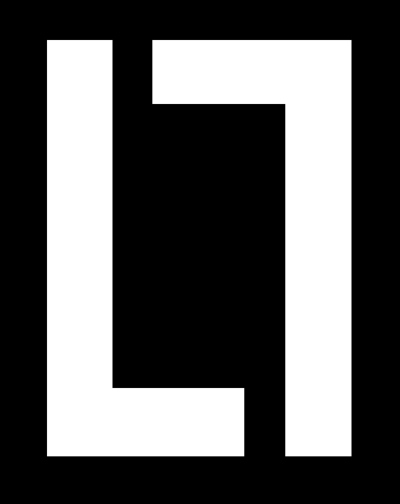Feliscatus-Nietzsche
Partecipa
Fino a
Feliscatus-Nietzsche
Comunicato
Di sicuro l'idea arriverà per il tramite del freddo che sento con le ciabatte infradito. Fino a tredici, quattordici gradi normalmente le porto senza accorgermi di averle, senza provare l'affilato sentore; anche questo, però, se si vuole, se non è eccessivo, se non è proprio intollerabile, si può imparare a dominarlo, direi anzi che per tenersi svegli e stare bene il freddo è utile e necessario. Ma qui, oggi, di gradi ce ne sono undici. Be', il bianco della neve non lo sopporto, mi gela la mente, ma il freddo, in fin dei conti, anche quando è talmente intenso da costringere gli altri a coprirsi e imbottirsi da cima a fondo, mi è indifferente. Più o meno. Sì, d'inverno meglio essere infreddoliti ca 'nsunnacchiati pu troppu cavuru.
Detto questo, di che parlare? Di Feliscatus? Quel Feliscatus che appartiene al passato? Il gatto domestico che non sono più? Di Feliscatus-Nietzsche, la prima parte di quel gruppo di lavori, che per seconda parte, dopo una fase intermedia ancora da definire esattamente nel significato e nella collocazione, ha avuto "La casa di Nietzsche", fatti l'anno scorso? O di pensare a farne altri per poterne scrivere dopo?
Ricordi d'infanzia: io che pianto nel palmo della mano di un mio amico una freccia tratta da un'asta di ombrello – a busa du paracqua –, alcuni tondini d'acciaio del quale, sganciati dalla raggiera e separati dai segmenti-sostegni collegati al legno centrale, erano serviti, legandoli con un filo di ferro, a costruire l'arco teso da una corda fatta con il prolungamento di quel filo che ne teneva insieme, avvolgendole, le aste componenti. E' di questo che potrei parlare? Io che, sbagliando mira, trapasso da parte a parte il palmo della mano destra di un mio compagno di giochi, in queste condizioni vedo che solleva la mano, stranamente non insanguinata, con le cinque dita tese e distanziate da spavento e dolore, dita che poco prima stavano cercando di sistemare il bersaglio, così come toccava a me farlo quando era lui ad impugnare l'arco, in un cumulo di sabbia da costruzione? rendendomi perciò conto di non essere né un abile pellerossa su un cavallo al galoppo, né Ulisse, né Robin Hood, né un arciere romano, né quel tiratore provetto che immaginavo di impersonare? che stavo sfidando me stesso cercando di far centro mentre il bersaglio veniva mosso?
Del fuoco che bruciò la casa-panetteria della madre lasciando la sua famiglia in difficoltà di non poco conto? Quel mio amico coraggioso che riusciva a mettere tutto il braccio nelle tane dei granchi per catturarli, senza aver paura dei morsi delle loro chele, da adulto divenne vigile del fuoco. Quando mi raccontava che il giorno della cerimonia ufficiale d'ingresso nel corpo dei pompieri era saltato sul telone dall'altezza di dieci metri – non ricordo se dieci piani o dieci metri, tanti comunque, dell'una o dell'altra unità di misura, e visti da sopra sembrano sempre di più che visti da sotto; come dire che più si è lontani dalla terra maggiormente si è portati a credere di esserne distanti più di quanto in realtà non si sia –, mi veniva in mente che da bambino mi feci male saltando da un muro di tufi alto due metri. Beh, non c'era il telone.
Di che parlare? Di me e una mia amica che in una tarda mattinata di molti anni dopo veniamo gentilmente pregati di lasciare un albergo di Arezzo perché le lenzuola durante la notte per amore si erano tinte di rosso? Io che alle otto di mattina esco da un albergo di Arezzo, mentre la mia amica conosciuta a Roma dorme ancora, per telefonare a un'altra donna incontrata l'anno prima?
Beccheggia col pollice verso una delle pagine indietro, quella ch'è vuota.
Una busta bianca, curva perché curvo è il certificato di autenticità che contiene – ché il cartoncino mantiene la curvatura come la carta non fa; quando si dice lo spessore! –, in realtà contiene la curvatura del tempo – che spessore ha il tempo? – e tutto ciò che avrei potuto fare e non ho fatto, che sarei potuto essere – o diventare – e non sono stato o non sono diventato; un po' la raddrizzo posandovi gli occhiali da sempiterno miope che per scrivere ha bisogno di toglierli – non necessariamente, ma se li tolgo scrivo meglio, senza che gli occhi mi si incrocino – comunque non ho bisogno di indossare quelli da presbite di persona anziana. Anziano, così devo definirmi alla stazione di Tortona per avere la riduzione sul biglietto per Milano che agli over sessanta spetta. E questa è una faccenda che non mi dà pace. Detta così è esagerata. Però ci penso, questo sì.
Poso nuovamente gli occhiali. Mi accorgo che i ricordi ora sono privi di inflessioni dialettali; essi non vengono dal luogo di provenienza, no, ma dall'intensità manichea con la quale venivano percepiti quelli che oggi hanno l'apparenza di ricordi, i fatti, il piacere, la sofferenza, i dubbi: odio-amore, repellenza-passione, mal di denti o non mal di denti, meglio: denti alla cui esistenza necessaria non si pensa quando male non fanno.
Oggi anche il mal di denti ha un altro colore; ora – io non ancora – il dolore soffre di vertigini. Gaspare non ancora, ma il dolore sì. Egli (il dolore) è affetto da spiegazzate, flessibili, acquatiche, longitudinali (comincio dal fondo) vertigini. Io, più bambino che adolescente, quando mia madre mi diceva: "ho dolore alle ossa", io, io mettevo in moto i cuscinetti a sfera, e, nel rumore di questi sull'asfalto, cercavo di capire quale fosse la senzazione del dolore alle ossa. Di che parlare? Di mobili da colorare perché non sono intonati al mobile accanto? o ai pavimenti? o ai muri? Di una donna e della sua richiesta di rifare il fondo di un disegno, si badi bene anche tra tratto e tratto, perché aveva cambiato il colore dei muri? Di appliques, suppellettili, lampadari che, come cani con le tendine di peli davanti agli occhi, riducono, dimezzano, offuscano, annientano la luce di una normale lampadina ma così fatti si presentano esteticamente gradevoli?
Di una lavatrice che perde acqua? Delle tende con intagli, pizzi, bianche o colorate da far venire il vomito? Quali sono le cose di cui parlare senza lasciarsi prendere dalla nausea per la casa da architetto con berretto, sciarpa e agenda e da designers in scarpe da tennis alla moda? Un tavolo, della giusta altezza, una sedia, comoda, un'altra sedia, prima di tutto utile, per chi viene a trovarti, scatoloni dove mettere i libri, una libreria cioè che puoi chiudere quando sei stanco di un posto e vuoi andare in un altro, un letto dove dormire, sognare, con una donna dar libero sfogo ai sensi finché ci sono; pezzi sanitari essenziali; non serve altro in una casa. Ah, sì, una cucina a gas, e, ovviamente, porte e finestre, per far entrare il sole. Basta, è già troppo. Pensare e scriverne è già troppo. L'ideale sarebbe una casa, possibilmente piccola, con le stanze che ruotano attorno all'entrata, senza mobili, senza nulla fuorché i muri. Pure senza quadri. Pure senza muri. Sostra. Una casa-deposito di legna, del carbone di quella legna bruciata, della calce rimasta o avanzata totalmente per quei muri mai costruiti, una casa vicino all'acqua, punto di sosta, punto di cambio: Sostra.
Un gatto domestico, e poi, chissà! Prossimo ai cinquant'anni feci diventare tutti i miei dipinti, le sculture, i disegni, i progetti, i cicli completi e gli altri da ultimare, tutto quello che fin lì avevo fatto diventò Sostra. Nuovamente firmai quanto già compiuto e firmato. Da quel momento, ma solo per quel periodo, fui Sostra. Ora lo sono e lo sarò. È Feliscatus che passa ad una parte di Sostra. E così si rinnoverà da solo, perciò in compagnia: Sostra.
Sostra, Sostra ocra, Siena, bianca, viola, blu, carminio, rossa, terra, carne, legno, Umore di fondo, Sostra indaco, di Cassel, gialla, nera, Sostra. Il lavaggio dei denti; un sacco di plastica steso sull'asta della doccia ad asciugare; un sacco di iuta dove far nascere e trasportare una vita. 1990-2004-2018.
Faesite, cartone, truciolare nobilitato, faesite, faesite, truciolare nobilitato, medium density, truciolare nobilitato, faesite, truciolare nobilitato, truciolare, cartone, truciolare nobilitato, ferro e colla, cera, cera morbida, truciolare e talco. Per tutti firma rosso di cadmio; scuola, scuola di gatti; case di gatti, chiocciole per corpi molli, bava di lumaca da cercare in un libro che non c'è più, in una libreria portata altrove, nella nuova casa; pavimento, muri e tetto per pensare, la graniglia delle piastrelle, il nero verticale, il grigio orizzontale, Il teatro di Vespasiano, La cavalla partorisce il mare, Getto d'acqua, biografia, recapito. Matita.
All'infondo! e, quando sarà, sottoterra; no! cenere; fuoco e cenere, e il vento che se la porta via. Un cervello che ha smesso di pensare è puzzolente poltiglia che di lì a poco marcirà. Di cosa avere cura? del marciume? Cosa conservare? un passato che lo stato attuale – che non è quel tempo trascorso – non potrebbe mai riconoscere come tale né utilizzarlo in futuro? Un corpo morto è un corpo morto. Ha smesso di esistere, e quel cervello ha smesso di progettare, ricordare, di aver coscienza di sé; il godimento del conoscere ha smesso, e gli abiti del progredire, ora mollemente in balia alla corrente delle fogne.
Ha smesso di imparare, quella rigida carne, di elaborare, quelle rigide nocche di giunture né astemie né ebbre. Ma quante sciocchezze raccontano gli oltremondani che su queste campano, lucrano, costruiscono fandonie; peluria estinta che mai starà in piedi o appiccicata di sporcizia perciò pigmentata e in piedi. "I fantasmi che fanno drizzare i capelli e imbiancare i volti". Le bugie hanno tre gambe: bracieri di monossido e sedute spiritiche, e occhi di bottoni automatici femmine. Le brunnie di bottoni di celluloide, d'osso, ferro, stoffa, legno, piene fino all'orlo; e quei coperchi porpora dentati! negli scaffali di un negozio emporio.
Foglie e fiori, foglie di bosco vuote; quando caleranno le cateratte degli occhi, fermi e andare. Solo quando verrà a mancare il gusto per la vita, giù nel cesso e tirare l'acqua (è finita la biro) non c'è più inchiostro nella biro (trascrizione del 31 marzo ore 18,30) - 2 aprile ore 18,50 (più corretta), se l'acqua ci sarà, altrimenti tirare giù il fango, che quello non manca. Il fango è sopra, sotto, di fianco e d'intorno.
La penna nel foglio deve scorrere come un esploratore armato e tutto indaffarato, che inizialmente cammina tirando le gambe, con un solenne incedere, più in alto che in un normale deambulare, e non conoscendo il terreno tasta a destra e a manca, gira, torna indietro, capovolge il foglio, scrive sulla via di una spirale immaginaria facendo ruotare il piano, poi in linee parallele prosegue, s'infila in spazi risicati, s'interrompe, va avanti in altri punti, saggia vie tortuose, scopre tracciati intermedi, olè, brevi! qualcuno è stato qui; ancora continua, fino a spossarsi, avere problemi di stabilità ed equilibrio, fino a riempire ogni piccolo luogo, espirando il fiato di un quarantennale, mnemonico, algido, adolescenziale, giovanile, maturo, anziano e non ancora senile – ma i vecchi non sudano più – mi fermo quindi ad anziano e per non sbagliare torno indietro di uno scalino a salire: attempato sudore. Che spasso la trascrittura! Che corse, che capriole, chi chianu, che spazi! C'era un antibiotico chiamato Amplital che per qualche minuto paralizzava, partendo dal ginocchio, tutta la gamba. Ma che tempi! Ingenui? illusori? balordi? sconnessi? Forse; in un certo qual modo sì, tutto questo e altro; però, le quinte azzurro-verde, i filtri giallo-verde; il colore che modificava il bianco e nero, il rosso tempestoso, inoffensivo per la carta, anzi amante della carta.
Poi venne la politenata che si asciugava subito e non occorreva smaltare, perciò niente rullo da passare, niente bolle da aggiustare, nessun ritocco da fare. La ripresa rossa dell'acqua, piombo fuso – così la chiamavano – nel rosso colorato di silenzio di una stanza dove le mani erano solite giocare per pochi istanti con la luce. L'arancione arrimazzava le smancerie dialettali di un cielo bucolico.
Il primo ingranditore che ebbi fu un Meopta Opemus III 6x6. Lo acquistai con cinque michelangeli insieme a tank, vaschette, pinze, bagni di sviluppo, carta, smaltatrice, da un emigrante tornato dall'estero.
La calma notturna, il buio appena rischiarato da quel brunito giallo, l'assenza di voce della ribollente oscurità d'attorno, l'odore di salsedine misto a quello di pomodori secchi, origano, basilico, bagno di fissaggio, adesso mi vengono in mente. Da quello studio sotto la terrazza nella quale si trovavano i due serbatoi d'acqua che dovevano bastare per due giorni e dalla quale da una parte vedevo a Muntagna du re con quel pollice monco sulla sinistra e il declivio gobbo sulla destra – c'era un tecnico che aggiustava le macchine da cucire che di pollici ne aveva due in una sola mano, suo terreno di intervento le Bernina, ma non si arrendeva davanti alle Borletti, le Necchi, le Singer, la Marco a sei teste con i cartoni perforati – dall'altra parte, dalla distanza di cinque chilometri, sempre con una certa quantità di salino piacere ed estatica stupefazione, guardavo il regno di Posidone, e di alghe, polpi, saraghi, cefali, cernie, ricci, infinite nuotate.
Ho lasciato la boccetta di vetro in mezzo ai libri, mettila da parte, poi vengo a prenderla.
E scorfani, che più che nuotare saltavano, con la loro struttura mimetica a spuntoni, addosso a rocce arrizzate subacquee. Lo scorfano, il Bacon dei mari, mentre il pennello intriso di colore stride e gratta il lato grezzo della tela, quello non preparato, quello che non si usa, quello nascosto, quello sul quale mettere la propria firma, qualunque essa sia, perché sul davanti basta la pittura: essa è la firma. Ma non lì, in quelle tele dipinte dal lato sbagliato perchè non ci sono i soldi per comperarne di nuove, lì il colore passando urla, non sottobanco, non sottotelaio, bensì alla vista di tutti, all'aria aperta, en plein air.
"Volevo dipingere una bocca che fosse come un tramonto di Monet, con due file di denti e un urlo ho constatato la non riuscita di quanto mi prefiggevo di fare. La bocca aperta nel grido è quel risultato mancato".
Verrà poi coperto da vetro per dare profondità alla pittura opaca, il cui olio d'ebbrezza è stato bevuto dalle assetate trame di lino nell'altra faccia dell'imprimitura; verrà coperto da vetro perché chi guarda possa specchiarsi, essere morto tra i morti, vivo tra i vivi; ricettore d'urli, pittura di sfregazzi nell'impeluccata tessitura terrosa di base: si urla con gole di carta vetrata, l'usura dei pennelli è accelerata dal lato non trattato della tela. Faccia di tela scura.
Ieri abbiamo comprato la lavatrice per la nuova casa. Una Beko, non per assonanza ma per convenienza. Ho letto che è una marca turca, le opinioni sulla qualità sono piuttosto favorevoli. Mariella ha preferito prenderne una non molto profonda che occupasse poco spazio in cucina.
Ho qui, attaccato al muro sul quale poggia il fianco della scrivania bianca, un ritratto a penna di mio padre del 19 settembre 1970; non ricordo se fatto dal vero o da una foto tessera.
I fogli su cui scrivo – adesso il rovescio del comunicato stampa da correggere della prima mostra di Sostra –, solitamente ripetute volte li sbarro a matita per evitare confusione e utilizzarne il retro dove traspare un po' il testo stampato sul dritto; in più, stavolta, per la matita morbida usata, non in trasparenza ma segnate per contatto, sono visibili le tracce di grafite nei punti della calcata scrittura a penna. Queste cancellature "primordiali" ante litteram, che in altri momenti mi avrebbero infastidito, oggi sono una nuova trasgressione, un invito a scrivere ciò che, quando sarà che verrà corretto, cancellerò ancora. È una danza del tempo, parole tra un prima e un dopo; un'anticipazione, un già fatto, l'eterno ritorno e l'eterno cambiamento in A4. Una parola, un insieme di parole, un lasso di tempo, una sequenza di tempi tra una cancellatura che a questo foglio appartiene per approssimazione e una per trascrizione che del foglio attesti la fine, il cambio della guardia nel proseguimento e mutazione.
Lasciare il posto ad altri: ecco il passo che nessuno vuole mai compiere. Magari a chi, per quel dato impiego, ha una competenza maggiore. Gli insetti lo fanno, gli umani no. I luoghi delle decisioni sono pieni di incompetenti, perciò niente funziona come dovrebbe.
La tenda che ho sistemato nel mezzo della galleria per le mostre temporanee mi convince. Tutt'attorno i muri sono coperti di dipinti di vari periodi che ho deciso di lasciare lì permanenti. Tra i quadri, inoltre, quattro sculture degli anni Novanta e la "Casa di Nietzsche" sempre del 1990, che allora si chiamava "Casa del sole"; la esposi in quell'anno, e da allora, smontata, ha vagato per i vari studi che ho avuto. È, quella, una scultura e un progetto insieme. Avrei voluto realizzarla in grandezza naturale, cosa che ovviamente non ho fatto. Come con voglia e grande soddisfazione avrei visto i "Cavalletti immanenti" alti venti metri con scale interne per poter salire fino in cima.
Un embrione della Casa di Nietzsche sta venendo su, si può dire spontaneamente, senza averlo progettato, né programmato, nell'entrata della nuova casa; attorno al passaggio, privo di porta, tra l'ingresso e la sala, ho cominciato ad appendere due stele con arance azzurre, e sulla sommità troverà posto probabilmente il sole radiante con la ruota immanente.
Si dice che a volte tutto va naturalmente, senza sforzo né sudati drammi, senza spericolati o sofferti desideri o euforica contentezza; che tutto va come deve andare, che gli eventi si svolgono con naturalità, rotolano, sebbene su sezioni esagonali anziché circoli di cilindro schiacciasassi, senza un minimo di attrito – è magia? – è volontà! in un luogo che la volontà afferma anziché negarla; se non avessimo avuto due millenni di terrificanti freni oggi gli umani sarebbero al di là del Sistema solare – freni menzogneri su ruote di catastrofi – e non in procinto di strappare la vita dal luogo che abitano. Sì, a volte le cose si svolgono proprio con naturalezza, ma non per questo danno gratificanti spasmi; di eccessi caratteriali non si sente il bisogno, perché, convinti, ci si aspetta che così vada.
Mio padre continua a guardarmi.
Stasera porterò qui la boccetta di vetro.
Semplice come versare acqua in un bicchiere e non berla, almeno per il momento, dato che non ce l'ho qui davanti – 11 febbraio, ore 17,14 – ho cancellato i segni trasversali a matita, calamitata con la gomma Mars plastic, 4007817504598. Un giorno questa gomma risorgerà dai trucioli di gomma, insieme ai segni che avrà cancellato; perché no? perché non dovrebbe risorgere? anche i rintocchi che suonano a morto, perché no? perché non dovrebbero risorgere? anche le statue che squagliate sono diventate campane, perché no? perché non dovrebbero risorgere? anche gli escrementi lasciati da un'impellenza in un campanile, perchè no? perchè non dovrebbero risorgere?
Freccia a destra e qualche settimana prima: la tenda di mistolino è sgualcita, in special modo nella parte bassa vicino al pavimento coperto dai tappeti grigi a righe bianche e blu, ma mi va bene così, ben si adatta alla carta coi bordi sfilacciati e impeluccati dei pastelli e i pluriball vissuti dall'uso e dagli spostamenti dall'uno all'altro luogo, dall'uno all'altro contenuto. Pluriball che tiene insieme, che avvolge e protegge, che dopo averlo usato andrebbe riposto tra le plastiche da riciclare, e invece no: rimane e diventa tamburo d'idee, lemmi di colori, supporto di pittura, lieve e trasparente, siderale; bianca musica lunare, ch'è musica d'immagini quand'è ora d'iniziare ad andar per sogni. Già, è il momento, preparatevi ch'è giunta l'ora, qui volano gli dèi del mito, e non cadono perché dove ci troviamo non c'è la caduta dei gravi, sono dèi che non pretendono di salvare e redimere un bel nulla, che non s'impicciano degli affari altrui. Questo pensavano coloro i quali credevano che gli dèi ci fossero ma vivessero in un mondo parallelo, facendosi gli affari loro senza ammiscarisi 'nte cosi umani; di cristiani, avrebbero detto i siciliani-spagnoli, col nome che da specifico e settoriale era diventato generico e assoluto, distanziatore dall'armali e 'mpruvulazzatu d'eternità.
La gente con poco cervello prende per conferme astrologiche, opere di magia o bagliori di chissà quale trascendenza, quelle che sono solo coincidenze, casi fortuiti – perché mai un caso fortuito non dovrebbe accadere se è nell’ordine delle cose? pleonastico trattino in prospettiva verso il basso che vive e brucia , e canta, afferma in aghi e vinile, gira e si consuma per i troppi giri, frigge, zoppica: su questi giri e un caffè a un tavolino di un anonimo bar di una qualsiasi stazione costruirò la quarta mostra di Sostra! –, oggi, portando nello studio dei libri d’arte che avevo nella vecchia casa, tra l’ultima pagina e la terza di copertina di una monografia su Pietro Longhi, ho trovato, all’interno di una busta di plastica, una delle ultime versioni della presentazione che dodici anni fa scrissi per la mostra di Frankenstein al Museo Orsi. Sette fogli dattiloscritti, da uno a sei e un cinque b, con correzioni a biro rossa e le varie giornate a cui il diario di lavoro, che allora per la genesi pittorica di Frankenstein tenni, si riferiva, evidenziate con una riga verticale verde posta a lato parallelamente al margine del foglio. I rinvenuti fogli – il retro – sto usando per scrivere il testo – penso che sarà l’ultima versione – per la prossima mostra, Feliscatus-Nietzsche, la seconda firmata Sostra, che probabilmente sarà in maggio. Questo di oggi è un giorno di marzo, è mia intenzione, al momento presente, non essere più preciso sulla data: sono le 20,35; è mia intenzione, in questo momento, astenermi da una maggiore precisione. Sono le 20,37.
Gent.mi Tizia e Caio,
ho allestito, presso gli undici anni di sogni, al numero undici, epici gradi sotto e sopra zero, centigradi Celsius e Fahrenheit di via Rinarolo, una mostra a lungo termine e ho il piacere di invitarVi a vederla.
In questo periodo, fino al 4 febbraio – ma è probabile che venga prorogata all'11 –, sempre nella stessa sede, è in piedi – letteralmente – altresì una mostra temporanea che è il seguito di tre precedenti, una mostra di Sostra – il cambiamento di nome dell'autore è questa continuità – dritta e flessibile, vibrata e ondulatoria, mitologica e nicciana, in una parola, anzi due, piemontese e dionisiaca: ossimoro non cercato; ma Torino, malgrado le apparenze, dionisiaca la è, con quel filo che attraverso le corone regali unisce le mansarde francesi e le piazze crepuscolari e deserte in quelle ore solamente strane che metafisiche non sono mai state; così come il carboncino e la pittura di De Chirico – gli ho sempre invidiato il labbro superiore sporgente, con il quale si può naturalmente osare quell'atteggiamento solenne, ingresiano scimmiesco a gambe divaricate non meno scimmiesche, quel portamento da dipinto polittico di cartone firmato Catus improvvisamente caduto ma come i gatti dal lato giusto; quell'andare adagio e sicuro con un centro di gravità corretto nelle impettite spalle, quel procedere, pennello alla mano e morso alle labbra, sia pure in pantofole, senza alcuna mimica forzata, pensata, imposta; perché no, costruita, realmente metà fisica e l'altra metà pure, l'arte chiamata metafisica è spuntata – semplice! – da lì a lì come la fine scontata di una singhiozzante attesa, con una strizzata d'occhio docilmente partorita dalla conformazione di un volto; sì come la cubista dalla faccia marmorea patinata a rughe bronzee, la voce a sorpresa, ma i denti spaziati e ferini di Picasso. L'arte chiamata metafisica che metafisica non è, tale la suppongono i tali estimatori presi al laccio con poco, in quella pittura di stentate pennellate del De nobiliare, diceva lui; quei dipinti con i tratti di scuola – non il disegno disassato nelle mancate corrispondenze del Doganiere, è nell'Avanguardia a pieno titolo costui, quanti viaggi mentali in terre lontane! – che, "metafisici", non posseggono le false attestazioni, procedure, motivazioni, esiti, neanche per esserlo in forma di suggestione, per diventarne poi, 'mpastannu i redini 'nto crinu baroccu, vittime dell'ingombrante etichetta di quella pittura aghiraedduci priva dei requisiti di favola che tuba: è la luce del sole, che tramonta o che sorge, non l'illuminazione di chissà chi a tagliare le ombre; sì, proprio come accadeva nel Borgo Schirò siciliano che io ricordo, lontanamente, perché viene da un dì lontano, ma presso due passi perché non smette mai di starmi vicino. Che stavo dicendo? Ah, in questo periodo – non mi sono perso, ho solo lasciato che la mano andasse senza pensare o temere il disagio di chi legge, io, o di chi rilegge, sempre io; quel velo azzurro, quella luce azzurra e quella luce ch'è solo normale; quella penombra azzurra, luce e ombra separate da un braccio, da un polso sbracciato; il self-service di via Dante con la libreria di fronte, poteva mai mancare quel nome adunco? Ante e case di ante, e la pompa del DDT rugginoso e mefitico, le mosche morivano e gli umani si gonfiavano e scoppiavano, volavano in cielo, palloni pieni d'aria e di veleni, di preghiere e assoluxioni. Non correggo l'errore di pria. Sarà Sostra in tre di sei segni, e taglierà quest'orrore di base.
Ancora, in questo periodo – e non occorre quindi ma lo metto –, quindi, si può incontrare una mostra di Sostra, perciò sicuramente ci sono – Sostra sono io! – nell'orario che segue: dal giovedì alla domenica dalle 17 alle 19. Dopo tale periodo possiamo fissare, al numero 333 6033006, un appuntamento per altri giorni e in altri orari a Voi comodi, adatti a vedere quadri. Un dipinto va visto nel tempo in cui si desidera vederlo; deve esserci il desiderio, la voglia di vederlo. Ma quando mai! Ma non è vero! Può accadere tanto di straordinario quando si è più che preda, complici della distrazione, questa sì forse desiderata assai (da italiano a siciliano non cambia). Come per la pittura, intendo dire farla; quante volte è solo un lasciarsi al nulla! un lasciarsi scuotere comu un cirnigghiu dalle mani del nulla. E i ficurinnia scuzzulati, scutulati a menziornu cu i pampini di viti! Una danza bacchica di lucciole-spine. Sta’ attentu all’occhi!
Solo? Da solo; da trent'anni non fumo. Le Muratti Ambassador, più o meno due pacchetti al giorno. Guttuso mi batteva, col mozzicone della precedente accendeva la successiva.
Un formale, cordiale saluto. Il mio numero di telefono era in calce (legna e carbone - Sostra, appunto).
Ci si vede e non ci si vede
Gaspare Sicula Sostra
L’eterno ricciolo della materia primordiale, dalla Z di Zarathustra alla a di Zarathustra; con l’acca, con l’acqua, con la pioggia che si fa mare, e quella parte di mare che pioggia diverrà. Punto, due punti. Ma sì, fai vedere che abbondiamo! Il Bignami di una battuta asservita ai propri fini. Fine. Punto e Sostra.
Bianco, giallo e Borgo Schirò, metafisico, religioso e politicamente corretto, quasi un’appuntita lancia di carta: oggi decrepito/oggi pesta, chi figghiu di buttana! perché pestata, perché calpestata, imbrattata negli archi a tutto sesto; e non solo, non sordo, non odo, come faceva Beethoven con la musica? Se diventassi cieco riuscirei a dipingere? Per l’e...sima volta poso gli occhiali – 0, 0, Nietzsche è morto; 0, 0, gli occhi del gatto di un nuovo secolo –. La musica e la pittura non sono uguali. La musica ha vie traverse, la pittura una sola, dritta e curva. La musica è un delta, la pittura è il mare; la musica è il canto, la pittura è l’urlo, la musica è un foglio piegato, un foglio sbilanciato, un foglio che va via, un foglio che brucia dentro, nelle voglie accartocciate. La pittura è un foglio annerito, un colore annerito da serbare in una sostra con legna, carbone e calce; bianco, marrone e nero, non rispettivamente, perché questa sostra è la sostra di Dioniso, è la sostra dei colori ebbri. Un tratto in calce di due millimetri di grafite e uno lieve di ritorno, sfumato e a uncino.
A questa sostra non serve il concetto di tempo, la preoccupazione del tempo, parte incassato, che sorregge, parte sporgente. Se ci sei batti un colpo, venti gennaio ‘18, cinque cerchiato, venti, trenta, quaranta colpi ha usato gennaio, li ha ripetuti febbraio, li ripeterà marzo, e poi aprile; in maggio si sente calura d’estate, giugno i colpi di sole, così è passato mezzo anno, sei mesi che verranno bissati, se sono sei batti un colpo.
Dieci fogli che stavo correggendo, titolati Venti gennaio ‘18 (odore di plastilina o di pastelli a cera) con numero progressivo da 1 a 6, 5 bis, bis bis, bis bis 1, 2 e 3 – i conti non tornano, dovrebbero essere undici, li riconto; sono dieci, difatti il 5 bis bis è già 1 –, li ho portati dal primo piano al piano terreno, dalla nuova casa alla Casa di Nietzsche, li ho fatti viaggiare in discesa, adagiati su una tela su tavola a olio del ‘98 di 20x30 centimetri (la stessa misura dei fogli a meno di 9 millimetri dal lato lungo e 11 dal lato corto, ma in quest’ultimo la curvatura dovuta alla pressione della biro sulle parole questa differenza se l’era mangiata): un paesaggio marino con varie brocchiglie galleggianti e un monumento sulla spiaggia ad una brocchiglia arborea, dalla quale, appunto, fuoriesce un albero; il dipinto è attorniato dal sottile filo di una vecchia cornice che comprai anni fa a Nizza. L’ho appeso al posto di un pastello di “Muri e porte” con una grossa e brutta cornice bianca. 18 febbraio 2018.
Nuovamente la curvatura di un foglio, la curvatura del tempo, lungo una discesa da una casa all’altra, da un piano all’altro. La curvatura di una giornata di nebbia. Ecco, se c’è una cosa che alla nebbia manca sono gli spigoli; al plurale, perché uno ce l’ha, l’angolo più che di visione di tatto.
Niente neve, niente ghiaccio; nebbia e freddo (neanche tanto, sopportabile); è ovvio, è il 31 gennaio. Mia moglie vuole che metta, nel lato interno della porta d’ingresso a primo piano della nuova casa, un pluriball per rallegrare il marrone scuro rossiccio appena venato dell’impiallacciatura del fondo. Avevo pensato alla Giulietta con le trecce di un dittico di una dozzina di anni fa con Romeo e Giulietta felini, se non ricordo male, però, i colori non sono molto chiari; mezz’ora fa – sono le otto e ventinove – mi sono messo a cercarla; trovarla, tra gli altri pluriball, non è un’impresa facile. Ho preso il primo rotolo che ho visto, dopo aver spostato un Casa di Nietzsche 70x100 su cartone posizionata davanti; l’altezza, che poi è la larghezza, di un dipinto in verticale, di settanta centimetri, andrebbe bene, tenuto conto della serratura. Apro il rotolo perché non capisco di quale dipinto si tratti: sono due, e il primo potrebbe essere maggiormente indicato di quello che stavo cercando, direi che è quello giusto. Un Cavallo immanente dipinto dieci anni fa; il secondo è un Ippocampo immanente tra le onde, dai colori più chiari e vivaci, dello stesso periodo, per la mostra al Museo Orsi. Ok, vanno bene. Farò decidere a Mariella quale dei due.
Il senso di dissoluzione, quando la lingua si posa su un dente cariato e spezzato, già riparato in tempi di muscoli ancora turgidi, con la lingua che continua a battere lì fino a dolere, in quegli avvallamenti inospitali o rilievi frastagliati e ostili e non su lisce superfici smaltate, anche lisce benché scure di amalgama plumbeo. E pensi a qualcuno cui non sia capitato ai denti posteriori, non visibili in un sorriso spontaneo, ma ne intravedi l’imbarazzo in un sorriso timoroso, pieno di pudore per non mostrare la resa di un dente, la disfatta di molti denti, la catastrofe di tutti; ho ancora tanti dei miei denti, cerco di tenerli da conto, lavandoli accuratamente e sciacquandoli a lungo. Van Gogh si dice che avesse denti malconci. Ma dalla sua pittura, sguainata e tenera, sguaiata nei colori ammorbiditi dalle forme, dai notturni accesi alla solitudine di un tempo, che non smette di piangere oasi di tranquillità, non traspare, non si evince, non affiora, non arriva. Parlo di Van Gogh ma è da tanto che non ne apro un libro, dalle cui pagine, devo dire, che non proviene mai odore di marcio. Mai però mi viene voglia di sfogliare libri su Van Gogh. Da giovane lessi le lettere al fratello Theo in un volume curato da De Micheli che le aveva pubblicate insieme a corrispondenza e scritti di altri artisti, sempre con quel taglio tipico di certa critica degli anni Settanta. Datata? – allora non trovavo differenza tra Topolino, Eta Beta, Tex, Storia del West, Diabolik, Satanik, Kriminal, Alan Ford e De la Tour o Hogarth – sì, assai datata e morta. Come L’Espresso di molti che non lo leggevano, da portare in bella vista sotto l’ascella.
Nell’aldilà si va coi denti cariati oppure integri? E ci sono i dentisti nell’aldilà? Che ridere! che ridere cariato! che cielo tarlato, che idee ammuffite, quanto odore di marcio! Aria stantia di cieli chiusi da secoli, insopportabile fetore; aria decomposta, truciulume di concetti andati, ordini purulenti. Menzogne, menzogne e basta, a cui taluni affidano la vita, l’unico segno che anno. Un visto rosso e andare. Una mosca in erba va a spasso. Qualche anno fa, durante una mostra, disegnando Isole, ebbi una mosca per amica. Basta, zitto e mosca. Per loro, che volano, questo mondo è sufficiente. La materia sulla quale posarsi non manca. Calda e a modo loro profumata; ma anche fredda, e dall’odore contenuto, riservato a pochi. Meno male che ci sono le mosche.
Noi, e i nostri rallentati movimenti!
Pure l’articolo sui Pink Floyd, che, calcando il testo, come sempre in questi casi, lisergico – con goduria morbosa ne poneva il significato enfatico come spartiacque nella responsabilità creativa – diceva di e su Barrett, ma il vero LSD è sotto l’ombra di una sola T. Meglio non parlare dei quattro altri rimanenti al riparo dal sole; l’inutilità delle parole usate da chi ne scriveva, solo luoghi comuni e stupidaggini in codice. Questi scrivono di musica! Altri cui venne tolto il sole hanno seppellito la T. Appena alzato: rumori di assestamento delle molle del divano. Ma nietzschiano è il dodici che mancava, in un percorso tondo di avanzamento verso l’eterno ritorno: tra l’1 e l’uno, nello status di unità tra cifre e parole. UNO: U per übermensch, coi puntini sconfinanti nel territorio del futuro che specifica, puntualizza; N per Nietzsche e O per anello del ritorno. ÜNO
Nella felinità del solitario, che c’è dove non c’è, c’è dove è già stata, nell’anello del ritorno circolare compresa la coda che dà la direzione e l’equilibrio, il funambolo si salva: allora inizia un’altra storia. Tutta da scrivere, o da disegnare, o da dipingere, oppure semplicemente da ascoltare, o da vivere che è la stessa cosa; no, non è la stessa cosa, la pittura cambia con l’età di chi la guarda. A vent’anni di una mostra di Braque non m’importò un fico secco. Oggi la mia reazione non sarebbe dissimile. Ho ancora vent’anni? O sento già la terra sotto i piedi e gli scricchiolii di altra arricciata, terra calcinata – come i fichi infornati –, ranciata, ingabbiata come le arance seppellite, infernale sabbia che comincia a ricoprire la testa ancora capelluta e scura? Cu sapi; in un disegno con la Sicilia accapputtata, con il nord al posto del sud e viceversa! che mi sovviene? Di una corsa di macchine sulle ondeggianti strade delle colline siciliane, l’unica che ho visto, non ricordo le macchine, il rumore mi colpì e mi torna in mente quando a quel giorno penso; veloce ad arrivare e veloce a sparire, l’assordante, fastidioso rumore; e che qualcuno m’insegnò che anche nell’amicizia non bisogna essere troppo altruisti, perché taluni possono trarne profitti cercati e pilotati, questo ricordo.
Cinquemila lire per un tamponamento, cinque euro per un libro di parole, un dizionario, il quattordici settembre di tre anni fa, forse lo stesso giorno ma cinquant’anni prima; no, non poteva essere lo stesso giorno, in quel periodo in Sicilia si vendemmia, si deve essere lesti di mani e forbici con i piedi ben piantati a terra, incollati alle suole di creta, sdrucciole quando sì quando no e per le quali il peso degli stivali aumenta di tre volte.
Il mio stile è una danza.
Io la danza cerco di farla con le forme. Quelle forme che spingo a danzare con le linee, con i piani, i volumi pieni e quelli vuoti, i bianchi e i neri: c’è-non c’è; così volli che fosse, così volli che non ci fossero. Non ho mai dipinto i baffi a Feliscatus perché per possederli, i baffoni, Feliscatus, Feliscatus doveva diventare Nietzsche-Zarathusra. Poi tramontare. E far sorgere Sostra.
Il quadrato perfetto è quello con il lato verticale poco più alto dell’orizzontale, in un calcolo che è da fare secondo necessità e ciò che al quadrato sta intorno.
Ridevo a pieni e soddisfatti voti davanti al vetro scuro, nel self-service da foto tessera. Poi sorrisi all’avvento di Frankenstein e alla prima mostra al Museo Orsi; quanto impegno! non lo rifarei; i dipinti giganti e le sculture alte quattro metri! Oggi mi mancherebbe la voglia di misurarmi con spazi così grandi, mi sono abituato ai quattro metri per quattro della 11Dreams e mi trovo bene così, forse sovraccaricandola, ma mi va bene così, circondato da pareti con dipinti attaccati uno accanto all’altro, la mia nuova-antica quadreria, le finestre sul mio presente, il mio passato, il mio futuro, oggi con l’aggiunta di una parete centrale, flessibile, di misto lino, mobile con le mobili gambe di Arlecchino.
Frankenstein, la creatura iberica, portoghese-ispanica. Ascpanu è il nome siculo di Gaspare, sa di ruvido, non levigato, bisogna stringere i denti e tirare su il labbro superiore per pronunciarlo, lo stesso che dire: veni cà, ti fazzu abbiriri eu! Il dottor Frankenstein, l’ascpanicu con lo sguardo atlantico, l’amor fati di Nietzsche capovolto un giorno avrà per nome Zarathustra, comu Frankenstein u fu pa criatura.
I disegni dall’1 al 18 sono stati fatti dal 10 al 14 maggio 2017.
Un sorriso gioviale, burlesco, a cinquantadue interni denti – la doppia fila di riserva in dote ai pescecani umani, io sono tra questi – come le stecche di una persiana aperta verso il sole del mattino e le tapparelle azzurre, quand’anche abbassate, di via Cuniolo quattr’occhi – quanti occhi! –.
È tratto da una foto di undici anni fa. Indossavo un giubbotto blu con cappuccio foderato di bianco. Ed è quello che a Nietzsche dà un’apparenza militaresca. Ma a smorzare questa impressione basta la camicia a quadri gialli e verde scuro con fili rossi e grigi, e la disposizione scomposta del colletto aperto.
8 maggio (o luglio?), ore 16. Ho appena finito di fare la doccia e mi sto asciugando i capelli in una camera da letto piena di sole, il fon acceso, io in piedi usando per pettine le mani. Nietzsche, il ritratto in creta, uno o alcuni dei tanti ritratti in creta, li farò come gatto baffuto, come leone baffuto, no, leone forse no; sì come aquila; e come serpente; aquila e serpente che spuntano fuori solo come teste dal fondo di queste piccole scatole-nicchie. Sto guardando – sono le 16,50 – al computer Gustav Klimt: A collection of 112 paintings; più precisamente ascolto il piano della colonna sonora del filmato alzando di tanto in tanto gli occhi per vedere i quadri zoomati in avanti che si inseguono; c’è un quadro che vidi su un’arrivista infame, negromante, cinquant’anni fa (la matita deve essere temperata, quasi scrivo – incido – col legno conico spuntato), un paesaggio puntinato con un enorme albero, il Klimt casto dei paesaggi pieni di punti – in quel periodo i miei genitori avevano un emporio-negozio dove vendevano di tutto, si raccoglievano punti per avere masserizie, si raccoglievano punti per avere premi, anche, all’atto pratico, di poca o nessuna utilità, quanto meno superflua, si cominciava a imbottire le case di roba di cui si poteva fare a meno; si raccoglievano punti per avere giocattoli, in un modo o nell’altro sempre utili, lo decidevano gli ancora imberbi che non avevano case da rimpinzare – e cerchi per foglie, e pallini per riflessi e luccichii nella parte bassa, ma proprio bassa, dell’acqua lenta ma non stagnante, e il poco cielo, più spicchio di prigione che liberatorio, che al mormorio dell’acqua serviva; certamente in quella rivista non potevano esserci i nudi, per quella rivista Klimt non aveva dipinto nudi. Mentre mi asciugavo mi veniva in mente il filmato che avevo visto prima di lavarmi, e cioè 181 works di Böcklin, soprattutto le Ville sul mare, e di conseguenza Franz von Stuck, mi tornava alla mente Eva (Il peccato) di Von Stuck, quella di Palermo. Come adesso mi torna in mente via Manzoni, nei pressi di piazza Cavour, con le facciate degli edifici di quella via, che passando dall’Hotel et de Milan arriva alla Scala, convergenti verso il centro, sia le facciate di un lato sia dell’altro, quasi a chiuderla in alto, quella via, soffocandola nel buio appena fatto di metà dicembre ‘91.
Dalle cinque di pomeriggio a dieci alle sette Medusa è rimasta spenta; una dimenticanza. L’ho accesa proprio adesso, poco prima di chiudere. Comprare acqua e carta stagnola. 18,53, 23 febbraio,
a capo, 2018.
Disegnando non si consuma la matita. È il nome che in parte sparisce; o meglio, cambia. La matita, le mine di grafite, rimangono come segno, non scompaiono, prendono forma di pensiero visibile, di immagine compiuta, dalla compiutezza ribaltata in fogli futuri sui quali a pezzi verrà riposta. I trucioli di legno e le briciole di pigmento li accumulo in un bicchiere di plastica trasparente, dall’esterno ne vedo aumentare il volume e il balletto delle arricciate forme; può darsi che un giorno mi venga voglia di impastarli con colla, così come facevo quasi trent’anni fa per ippocampi e cavalli quadrupedi a tutto tondo e bipedi in basso e alto rilievo.
È l’HB che si consuma; la parte bassa di quelle due lettere che sembra abbiano usurpato il posto e la grassezza o la poca durezza – buona per tutti gli usi, di qua e di là, né di qua né di là – occupata un tempo dalla sola B, quando quest’ultima, per essere utile, aveva bisogno che l’affiancasse un 2, per essere idonea su carta ruvida anziché liscia, oppure sulla parente povera, che ad un costo inferiore poteva permettere una maggiore dimensione – 100x140, tagliata in due per avere il 70x100 –, qual era la carta da imballaggio bianca usata dal lato grezzo. Economica e utile per le figure, il vero; mentre la carta più pregiata, dai suoi cinquanta per settanta di assenza, bianchezza e ruvidezza, smaniose di essere intaccate dalla B2 (2B) – formula chimica per le idee da pane e panelle a mezzogiorno, perciò a ora fissa (ecco il freno, ecco il blocco, ecco l’usura, ecco la “normalità”, ecco la ripetibilità, ecco l’assuefazione, ecco il rifiuto, mai la pittura su commissione!) – appuntita su carta vetrata, era adatta a rendere porosi e neri i calchi incolori e lisci con le loro esangui facce di gesso, nel quotidiano tributo alla classicità greca.
Uno dei tanti volti plastici di Nietzsche che farò, per adesso, quindi, di un luogo immaginario.
Non ho utilizzato stecche per modellare. È da tanto che non lavoro la creta, per cui non le ho più. Chissà, ma proprio chissà dove sono andate a finire! Incastrare di continuo le cose in uno spazio che non è mai sufficiente a tenerle in ordine porta allo smarrimento la memoria mappale del luogo, col naufragio e la dispersione in una confusa deriva dell’armamentario annesso; e la raffigurazione sovrapposta dei momenti che di tanto in tanto trovi appesa qui o lì, in terre a sorpresa o protettive – per scelta di allora – tane impensabili, ora dimenticate – ci vulissiru i cani cacciatura – : ricordo che l’avevo messa là in fondo, al sicuro, perché sicuro che l’avrei ricordato. Solo a ritrovamento avvenuto, però. Di lì a poco ritornerà in balia alle onde nell’alto mare della confusione, vagante sopra un esausto spettatore arenato sul fondo. Per adesso: com’era facile, ciò che cercavo tanto l’ho cercato, trovarlo dopo averlo trovato, ecco dov’era!
Cu u sapi si esistinu ancora, ‘nta quali agnuni sunnu sarvati, ‘nfilati, o, megghiu, ammucciati; sia quelle di opaca plastica grigia, scolastiche di primo pelo, che avevo conservato e utili erano tornate in seguito, sia quelle più professionali, da liceo, di legno e ferro, con quell’apparenza, quand’anche scissa dalla funzione, di per sé formalmente interessante, quell’interscambio tra resistenti linearità e lignei volumi nella destrezza bifronte di artista-giocoliere, detentori di bella forma da donare, esteticamente creditori di interessi che andavano al di là dell’oggetto d’uso, proprietà di struttura che richiamavano alla mente Moore con i suoi ossi da spiaggia, Giacometti con le ceree, tremebonde, denutrite, edipiche gocciolature digitali, Picasso con ceste, cartoni e macchine giocattolo, palme e parabole di corde che saltano, capre e zinne gonfie di latte; Tinguely con i suoi marchingegni di ferro e il carrettino da recupero con l’archivio di robivecchi, e la sua donna Niki, il buongiorno solare, mediterraneo, spagnolo, catalano, bianco e colorato del Pompidou. E il Manifesto blanco? Vada per i tagli, ma le sculture, che bruttezza! anche quelle non spazialiste – secondo la sua etichetta – ma figurative di ceramica, oppure quella specie di balle fantozziane di bronzo, maltenuti pouf in cantine piene di topi meccanici privi di polso, rituali, ripetitivi; deleteria, costantiniana e plumbea novella grandine dell’aldilà.
La scultura smiciaciata di Melotti devo dire che non mi ha mai attirato, neanche un po’. Con tutto quel bianco e quell’abbuzzatu e stortu lamierino giarnu d'ottone. Trovo queste intirizzite costruzioni più come una stecca malcavata che altro; nata male, una stecca che si è guastata in quanto “questo pezzetto lo metto qui o là è lo stesso” fragile in accostamento, sopraelevazione e pensiero, non adatta allo scontro oppure alle effusioni con la creta, che in un combattimento a due ne esce perdente, o in un amplesso batte in ritirata molliccia, la stecca, non la creta. Quanta differenza con le donnone di Picasso, o le spilungone trappole elettriche di Giacometti; la forma, mai dimenticare la forma! La scultura è lo stridore sottomarino di un pesante mobile spostato; è lo strappo della carne nel polpastrello ghermito dall’incastro di uno dei piedi del mobile. Somiglianti erano, chi aiutava e chi era aiutato: I want to live è caduto!
Ho adoperato le dita, ho usato penne esaurite, matite, cacciaviti piatti, graffette, coltelli, coperchi di penne, per scrivere non con inchiostro, ma con un segno inciso, non sulla carta, bensì su terra.
Non sono busti, né immagini votive, né ricordi di fisionomie, né immagini di un divo imperituro; se mi fosse riuscito di ritrarre la puntigliosa ricercatezza sotto i baffi – cosa rimane del cibo mangiato? – di un’alimentazione programmata e accurata! mi sarei limitato a questo, e sarei stato contento; ma io non voglio essere contento. Un rumore di qualcosa che s’è spezzato, comu di canna ciaccata, lo scontro tra graffetta e grafite. Ma la grafite non si è rotta, la canna è al vento, la d è la d. Alla canna è appesa una gazza a testa in giù. È un vento venuto dal nord, è freddo, anche questo è odore di Sicilia e silenzio. Quanta strada occorre fare per sentire una voce umana, che bello! Poco consumo e poca spazzatura, una volta si riciclava per bisogno, non si sprecava, non lo consigliava né lo imponeva nessuno. Venivano a prenotare le scatole vuote di cartone nel negozio dei miei genitori. C’è un tubetto di colla chiuso che tende a incollare le pagine di un libro, tante pagine, si parla di musei, molte con immagini, nulla di importante. Ma quali stanze dell’armonia! Quella è una sciocca visione dell’arte. Perché armonia? Ecco dove ci ha portati quel tipo di a-r-m-o-n-i-a, aArRmMoOnNiIaA. Cosa rimane del cibo ingurgitato? Mangiare o ingurgitare; cibarsi o abbuffarsi. È tutta qui la differenza.
La grafite del mozzicone di matita iersera s’è rotta, mentre la stavo temperando per appuntirla: dovevo seguire il profilo del reggilampada; quell’arnese di plastica che con l’aiuto di un morsetto serve a fissare la lampada a molle da disegno tecnico, residuo degli anni di architettura, dovevo incollarlo su una base di compensato di due centimetri di spessore, ventuno di larghezza e ventisei di lunghezza. Stasera si è nuovamente rotta. È un fragile residuo di matita che va sempre più riducendosi: la sua vocazione è distruggere, non creare. Questa è una matita adatta a cancellare, a togliere. Alla scultura del togliere preferisco quella del mettere. In un blocco di marmo non c’è già la forma, ci possono essere innumerevoli forme, proprio come in un blocco di creta, non c’è alcuna differenza. Da una parte si toglie quel che è in più, dall’altra si aggiunge quel che è in meno. D’altra parte è meglio carezzare la terra che bombardare le montagne. Primo comandamento: non calcare la mano. Secondo e ultimo, che la terra asciughi il tuo sudore.
Siamo incudini, siamo martelli.
3 marzo, ore 21,45
Chissà perché ho pensato a Riccardo III. II versione: mi è venuto subito in mente Riccardo III.
Prima di Shakespeare, poi con Al Pacino doppiato da Giannini. Il docufilm, così chiamato. Il secondo Riccardo III non è Olivier, questi lo lascio a Van Helsing. Amleto è Branagh, mai Gassman, mai Zeffirelli.
Sono andato a buttare una vecchia bacinella quadrata di plastica azzurra che si sfogliava. Neve per strada e sulle macchine. Il coperchio del contenitore della plastica si sollevava con difficoltà perché coperto a sua volta di neve. Mi sono sporcato le mani. Aperta la galleria ho preso la direzione del bagno per lavarmele. Mi sono ingobbito per tirare su le maniche della giacca a vento non potendolo fare con le mani sporche; è la giacca che prediligo – ne ho altre due, una pesante come uno scafandro che non metto mai – (a seconda della temperatura di colore della luce e dall’angolazione da cui si guarda, il grigio scuro, che è il suo colore, vira in un grigio violaceo) perché non mi fa sentire freddo né troppo caldo. Continuo a indossarla sulla camicia, oggi nera come i pantaloni. Mi sono detto: pensa un po’, Gaspare-Sostra, se tu fossi così, se tu per una malformazione fossi stato sempre con la schiena curva. La mia immagine allo specchio mi restituiva la problematica domanda-condizione di questo aspetto. Chissà perché ho pensato a Riccardo III; mi è venuto subito in mente Riccardo III.
4 marzo
Stamattina ho guardato verso i tetti. Persino il bianco, e il nero di cui quel biancore solitario ama circondarsi, sia il primo, sia il secondo con le sue cadenti sfumature di tristezza, tutt’e due mi sembravano così pieni di colore!
I baffi li modello come se fossero una barriera, un argine di creta, in uscita e in entrata: nel far uscire idee e nell’introitare cibo, le dita allungate, le unghie sugli occhi vivi, nell’eterno ritorno di una ostinata, imperterrita improvvisazione. Quella musica è lo spettacolo delle forme, è danza; quella musica è la danza delle forme, è la musica di chi, vivendo appresso vivendo, non abbisogna di correzioni di pensiero. Il pensiero corretto! Ma no! Il tempo della parola è morto. Ecco qual era il vero senso dell’eterno ritorno: l’assenza, fare il pieno della propria assenza. In uno studio ordinato my way i riflessi non sono retrattili, sono ombre; di un litro e mezzo d’acqua dirò quel tanto che basta; dell’acqua in una bottiglia di plastica guizza maiuscola/minuscola dirò quel che occorre: che proiettava sulla tela vibrazioni di luci e ombre nelle quali vidi l’aspetto di Frankenstein, creatura e creatore. La stampigliatura dorata della HB è divenuta accaerre con una acca dalle gambe corte. Rotola la verità, la menzogna scoppia e precipita. In una piccola scatola, le lampadine di ricambio di Medusa corta, la prima. Saranno undici? Saranno tredici? Gaspare-Sostra apri la scatola e vedi. Quarantadue fori, trentasette mancano, cinque lampadine ci sono. 09WE512V.
Sostra
feliscatus@sicula.com www.sicula.com
Come arrivare
- letto 1723 volte