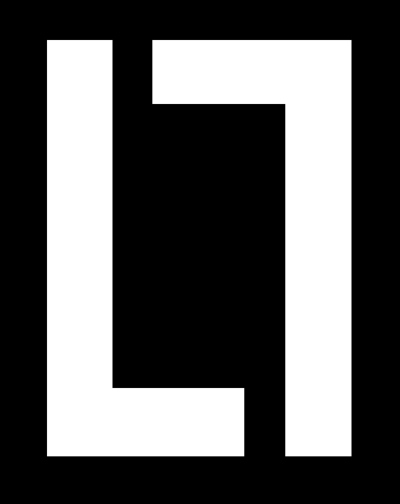Vedute d’arte. Immagini di paesaggio sull’Alpe Cimbra
a cura di Warin Dusatti
Maso Spilzi – Costa di Folgaria (TN)
19 luglio – 13 settembre 2020
mart. – ven.: 16.00 – 19.00
sab. – dom.: 10.00 – 12.00 / 16.00 – 19.00
Vedute senza visione al museo di maso Spilzi
di Annamaria Targher
Per l’estate in corso, l’amministrazione comunale di Folgaria ha annunciato il ritorno della pittura nel magnifico fienile di maso Spilzi, proponendo una mostra che documenti il rapporto intrattenuto da taluni pittori con il territorio.
Ciò che non era lecito aspettarsi, però, era una trita replicazione delle felici e gloriose esposizioni passate (si ricordi l’esaustiva Altopiano dipinto, 2004), senza che qualcuno abbia anche solo potuto supporre che fosse possibile immettere della contemporaneità, quantomeno un sussulto di rilettura della storia pittorica degli altipiani e che ci si limitasse, per converso, a rivolgersi ai soliti prestatori che dispongono di pezzi squisiti, altisonanti, anche se magari non contestuali ad un progetto che stenta ad essere rinvenuto in tutto il percorso espositivo.
Il parametro temporale, infatti, appare alquanto debole, labile e alfine pretestuoso: da solo, infatti, tuona e quasi stona un solitario, intimo e romantico Lavarone di Domenico De Ballarini (1803 – 1891), unico esemplare sperduto, quasi dimenticato e afferente l’Ottocento in mostra.
D’altronde, se la giovane assessora alla cultura, da cui dipende il funzionamento e l’organizzazione, aveva annunciato come “tradizionale” la mostra tuttora in corso, è chiaro come il risultato possa essere in linea con i propositi decisamente remissivi, timidi, nel solco non indagatore.
Alla stregua dei sommessi propositi, però, verrebbe legittimo chiedersi come mai, a fianco di un titolo consono, quasi ottocentesco, nostalgico che prelude alla lenta, pervasiva e sintomatica visione di paesaggio, si sia affiancato l’oramai immancabile, quando si parla di turismo e di marketing, brand, perché questo è a tutti gli effetti, Alpe Cimbra, senza che tuttavia ci si lanci, anche solo minimamente, nell’escursione dei dati del contemporaneo e dei suoi fautori.
Inoltre, il titolo, che dovrebbe racchiudere un’indicazione, viene chiaramente tradito dalla riproduzioni di scorci montani decisamente avulsi dall’ambiente in questione.
Quella che appare con evidenza agli occhi del visitatore, invece, è un’accozzaglia priva di senso, in cui pezzi davvero potenti risultano fuori luogo, quasi non concomitanti, se non addirittura fuorvianti.
Gli stessi Fortunato Depero (1892 – 1960), se si eccettuano le rappresentazioni contestuali delle chiese locali, appaiono sganciati, sempre e inderogabilmente imperiali, ma sicuramente non addentro il percorso espostitivo: ne segnano, piuttosto, il passo, arrivando a invalidare i coevi esiti degli altri pittori, isolandoli e relegandoli in un ambito quasi naïf, senza tessere relazioni o proficue discontinuità, non accumulando, infatti, punti di vista diversi, pur nel medesimo, comune sentire. I pezzi del sommo si stagliano legittimi parlando di paesaggio, suonano stridenti quando propongono narrazioni indipendenti, che diventano incongrue, perché non identificative di nessun territorio.
Dello stesso Luigi Vicentini (1901 – 1970), inoltre, che non ha partecipato di fatto alla stagione sull’alpe dei pittori in mostra, solo un’opera ritrae la magnifica Serrada vecchia in un ben riuscito omaggio alla pittura cezanniana di Diego Costa (1897 – 1979): i restanti, che tra l’altro appartengono sicuramente ad un periodo un po’ debole del pittore, rimandano ad altro.
Sembra, inoltre, impossibile la dimenticanza e, quindi, l’assenza di un eccellente pittore, tuttora attivo tra la Francia e gli amati Rocchetti di Lavarone, quale è Serge Micheloni (1929) e la cui nonna è nativa del suggestivo borgo dei Perpruneri. Esperienza pittorica che si è sempre raffrontata col dato locale, arreca come un’incessante e irrinunciabile implementazione l’esistenza d’oltralpe e di respiro internazionale dell’architetto pittore che mantiene da sempre gli occhi ricolmi della luce e delle forme della sua terra natìa. Il reperimento dei pezzi significativi sarebbe stato agevolato, tra l’altro, dalla loro disponibilità in seno alla stessa famiglia dell’artista.
Un allestimento sotto il segno del ribasso, non problematico, ma sommario e che ha prediletto, senza apparente necessità, l’angusta risoluzione dell’allineamento in basso esita l’evidente demerito di risucchiare e svilire pezzi straordinari, anche se piccoli e preziosi al pari di lucenti cammei, come Serrada (Martinella) del già citato Costa.
Il ballatoio del fienile è riservato alle glorie locali. Lo stacco è naturalmente ben definito dallo spazio raccolto, risultante dalla sua rannicchiata collocazione in alto. Lì si trovano gli Alfonso Cappelletti (1891 – 1946) provenienti dal lascito della famiglia alla comunità.
Con l’occasione, sale alle luci della ribalta il pittore serradino Guido Valle (1905 – 1960), precedentemente misconosciuto ai più: entrando a pieno titolo nella rosa dei grandi che hanno ritratto l’altopiano e che viene a ritrovarsi in analitica e prestigiosa relazione, ad esempio, con le betulle di Vittorio Casetti (1891 – 1977). Un precedente importante era stata la sua pubblicazione sulla rivista Arte Trentina n°2 a nome dello storico locale Paolo Dalla Torre che firma anche un contributo in catalogo e il cui direttore responsabile è anche il curatore della mostra. Pittore modesto, eppur sincero, i cui prestiti provengono quasi tutti dagli eredi, emula per sommi capi e senza pretese i nomi prestigiosi che si ritrovò al proprio fianco: dalle masse tridimensionali del Costa, alla neve calma e silenziosa di Elio Martinelli (1891 – 1967).
Nonostante le buone e dimesse intenzioni, è evidente come, un dilettante suo malgrado, si venga a ritrovare catapultato nell’olimpo degli eccelsi pittori, in maniera del tutto casuale, ricoprendo di accidentalità tutta l’esposizione che dovrebbe invece intrecciare significazioni, lasciare un’impronta, costituirsi, nel flusso del tempo, come un punto fermo e non come un’eccentrica fatalità dove tutto può essere concesso e accolto, per essere ingurgitato ed esposto.
Perché questa forte sensazione di disorientamento sovviene sin dall’ingresso: dove ci accolgono i due monumentali Attilio Lasta (1886 – 1975) Meriggio sul Grosté e Tramonto sui Crozi Rossi) di evidente impronta segantiniana che sembrano oscillare, a questo punto per spaesamento e per relegata esclusività, come due colonne d’Ercole all’ingresso di una raccolta di quadri, intesa nulla più che come un’involontaria accumulazione.
Perché, come insegna il buon Bauman, a nessuno è venuto in mente di tessere un filo che diventi nodale, ad esempio, tra esperienze locali e velleità oltreconfine che trasudino però autentica identità, come il buon Micheloni insegna e che il sociologo ha circoscritto in quell’abile, sempre valida definizione, tramite lo straordinario neologismo glocal (superba crasi di globale e locale)?
C’è da augurarsi che il museo di maso Spilzi torni ad essere fulcro per esposizioni di livello come ben si addice alla sua innata bellezza: di respiro, di audacia, di visionarietà e non un concitato riempimento occasionale che svilisce al pari, se non peggio, di una forte impronta curatoriale, i singoli risultati che, nel cozzare e respingersi tra loro, perdono inevitabilmente di forza, potenza e, perché no, candore.
Annamaria Targher